Il testo riporta una newsletter che ho inviato il 13 agosto 2023.
PARTE 1: Desiderare fuori dall’immaginario capitalistico
Sono giorni che non riesco a togliermi dalla testa alcune immagini che trovo siano molto esemplificative di un concetto di cui vi parlo spesso: l’incapacità di prendersi per mano e ragionare in termini collettivi e di cura. Eppure, nonostante tutto questo caos, siamo ormai completamente anestetizzati dalla pervasività dell’immaginario neoliberista. Un immaginario che ci vuole tutti soli, isolati nella nostra individualità, convinti che la competizione sia l’unica via, anche nei nostri desideri più intimi.
La settimana scorsa le strade di New York sono state prese d’assalto da oltre 6.000 giovani, provocando una vera e propria rivolta che ha infiammato Union Square e che è poi culminata in feroci scontri con la polizia, numerosi feriti e oltre 60 arresti. La metà delle persone portate via in manette erano minorenni.
Ciò che ha spinto i giovani a scendere in strada, l’elemento scatenante della loro “rivolta” però, non è stata affatto una richiesta di cambiamento politico o sociale.
I ragazzi che lanciavano sassi e oggetti contro le forze dell’ordine non stavano rivendicando un salario dignitoso, la sanità pubblica universale o l’accesso all’istruzione. E questo nonostante vivano in un Paese segnato da disuguaglianze economiche profonde, dove la legge sembra punire soprattutto i più poveri (migliaia di senzatetto arrestati per vagabondaggio, ragazzini incarcerati per infrazioni minori perché i genitori non possono permettersi di pagare una multa o una cauzione, ecc…). Anche se la maggior parte dei presenti era afrodiscendente, gli scontri a Union Square non avevano nulla a che fare con il movimento “Black Lives Matter” — un movimento di cui, una volta spenta la FOMO dopo la morte di George Floyd, non si sente quasi più parlare.
Ma allora, perché erano lì? La risposta è cinica quanto sconcertante: per un giveaway. Non per giustizia sociale, ma per cercare di mettere le mani su una PlayStation 5, un PC o delle cuffie da gaming. Tutto orchestrato da Kai Cenat, lo streamer più seguito d’America, che aveva invitato i suoi 6 milioni di follower a raggiungerlo, promettendo di regarli ai suoi follower. Insomma, non una rivolta, ma una caccia al tesoro, in cui la rabbia sembrava alimentata più dall’assenza di gadget che da qualsivoglia ideale.
Inutile dire che il 21enne non perde occasione per esibire uno stile di vita praticamente inaccessibile alla stragrande maggioranza delle persone, incarnando un edonismo individualista che ruota attorno alla glorificazione di sé e all’ostentazione sfacciata del lusso. Tutto questo, come suggeriva Thorstein Veblen con il concetto di "consumo vistoso", non è altro che un disperato tentativo di emulare la ricchezza e di mostrare al mondo un riscatto sociale attraverso simboli esterni: come l'immancabile “ghiaccio” – cioè il freddo delle collane d’oro e dei diamanti indossati. In fondo, non c’è nulla di nuovo: un teatrino ripetuto da secoli, in cui l’acquisizione di uno status materiale è la via più breve per comunicare potere e successo, ignorando completamente l'illusione che tutto ciò rappresenta.
La situazione però è degenerata rapidamente, portando la polizia ad attivare un intervento di “Livello 4”, cioè la categoria più alta per quanto riguarda le risposte ai disastri da parte delle forze dell’ordine americane, con le immagini degli scontri accompagnate da parole come “sommossa”, “maxi-rissa”, “caos”.
Qualche giorno più tardi un video diventato virale su TikTok dalla caption “Oxford Circus JD Robbery” incitava gli utenti a ritrovarsi nel negozio di articoli sportivi JD sports di Londra per compiere una rapina di massa, con tanto di richiesta di indossare guanti e passamontagna. L’intervento della polizia ha scatenato una maxi-rissa tra i giovani e gli agenti, con 9 arresti e la Ministra dell’Interno, Suella Braverman, che chiede il pugno duro contro “gesti anarchici”.
Quello che hanno in comunque questi due episodi è di rendere lapalissiano il fatto che nell’era contemporanea ciò che siamo non rispecchia più un sistema di valori condivisi, il modo in cui ci definiamo come individui non è più assoggettato ai dispositivi etici, morali e ideologici che determinano il nostro agire nei confronti del mondo e degli altri, perché, ormai, ciò che siamo, passa necessariamente da ciò che possediamo, inteso come l’apparato dei beni di consumo e delle “experience” che possono posizionarci come individui all’interno di rapporti di forza declinati secondo principi di potere, spesso puramente estetici.
In questo senso, i social operano come un dispositivo repressivo, di controllo, perché, costruiscono attorno a noi un immaginario che plasma i nostri desideri e li disciplina alla conservazione del sistema, un sistema che ha al proprio centro l’overproduzione di beni di consumo.
Come sottolineato qualche giorno fa dal giornalista Federico Mello, ciò che è successo negli scorsi giorni a New York e Londra è un “causa-effetto” del sistema privo di ideali, politica e amore che abbiamo continuato giorno dopo giorno ad alimentare, celebrando da oltre un decennio “gli influencer nullafacenti e la loro ostentazione del lusso, delle marche costose, di consumi esclusivi”. Ciò che viene rappresentato attraverso i social, l’immaginario di cui ci nutriamo tutti e tutte, è uno spettacolo che impone costantemente di consumare attraverso processi di omologazione.
In “Acculturazione e acculturazione”, un testo pubblicato nel 1973 da Pasolini sul Corriere della Sera con il titolo “Sfida ai dirigenti della televisione”, lo scrittore parlava della rivoluzione del sistema di informazione derivato dalla diffusione di massa della televisione in modo molto simile a quello in cui potremmo parlare oggi dei social network: “[La tv] ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un “uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane”.
Continua Mello: ”Da anni, nelle loro inutili foto, si vantano dei loro orologi da 50mila euro (Fedez, in realtà, continua a mettere in primo piano nelle sue stories la new entry firmata Hublot, un Big Bang Unico Sapphire Baguettes da oltre 500.000 euro), delle loro vacanze a 20mila euro a notte, delle loro Lamborghini, delle loro case da sogno, dei loro jet privati, e nessuno dice niente, tutti a fargli l’applauso. Poi oggi, i follower che sono cresciuti con quei modelli e che quei consumi non se li possono permettere, che fanno? Si organizzano per svaligiare i negozi”.
Come dicevo, il sociologo Thorstein Veblen nel saggio del 1899 “Teoria della classe agiata” spiegava perfettamente questo fenomeno: nel capitalismo, i beni detengono uno status più elevato del personale. L’autore parlava di “conspicuous consumption”, un consumo ostentativo: la classe dominante si rivolge a beni appariscenti e di lusso perché è legata a logiche "posizionali", in cui le scelte, cioè, sono determinate dalla necessità di esibire i segni esteriori della posizione e del prestigio acquisiti nella scala sociale, che sono l'effetto, a loro volta, della ricchezza monetaria raggiunta e del benessere acquisito. A questo tipo di spesa si collega, dal punto di visto della motivazione al consumo, il comportamento emulativo delle classi più basse, che aspirano anch'esse agli stessi beni "vistosi", per simulare, in questo modo, uno status sociale esteriore opulento e superiore a quello reale, che li avvicini alle classi economiche dominanti.
Nel mondo dei social, a mantenere in piedi gli equilibri di potere e a stratificare quell’immaginario capitalistico che ci circonda c’è una nuova aristocrazia: gli influencer. Questi personaggi, lungi dall’essere semplici promotori di prodotti, sono i veri e propri vassalli del sistema, difendendolo con dedizione quasi servile. Non sono solo i messaggeri della spinta consumistica, ma anche i guardiani di un ordine economico che arricchisce i pochi a scapito dei molti.
Pensate, ad esempio, a quelle "influencer attiviste" che si sono vendute a SHEIN, partecipando a un finto viaggio orchestrato dalla nota azienda di fast fashion per ripulire la propria immagine dopo le polemiche sullo sfruttamento dei lavoratori e sulle condizioni disumane del loro sistema produttivo. Un vero e proprio spettacolo di propaganda, spacciato per trasparenza, in cui queste influencer hanno prestato il loro volto all’ennesimo tentativo di riqualificazione del marchio.
E come non parlare di Mondo Convenienza, che nel bel mezzo di uno sciopero di quasi 80 giorni, con lavoratori licenziati e picchiati per aver chiesto diritti basilari, si permette di organizzare "challenge" sui social? Tutto per mantenere alta l’attenzione e l’engagement, mentre nel mondo reale si consumano abusi sotto gli occhi di tutti. Ma chi se ne importa della realtà, quando un like o una condivisione valgono molto di più? In questo tecnofeudalesimo, i signori digitali ci danno illusioni di partecipazione, mentre i lavoratori reali restano invisibili.
Prima di togliersi la vita Mark Fisher tenne una serie di lezioni in cui si interrogava su qualcosa che mi rompe la testa quasi ogni giorno: desideriamo sul serio ciò che sosteniamo di volere o ciò che desideriamo è mediato dal sistema in cui viviamo, produciamo, amiamo?
Quello che si chiedeva Fisher è: esiste un desiderio post-capitalista, ossia la capacità di desiderare qualcosa che non sia già stato individuato come desiderabile dal capitalismo?
«Il capitalismo è definito da una crudeltà incommensurabile, perché ci fa morire gridando viva il capitale»
Ok, se la mia newsletter ti piace e ti stai chiedendo come offrirmi un caffè virtuale, la risposta è che puoi farlo qui: https://buymeacoffee.com/serenadoe
Discussione su questo Post
Nessun post







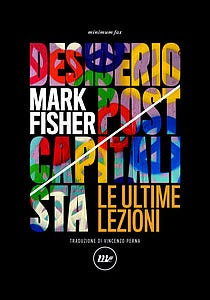
Grazie Serena, è sempre emozionante ed arricchente leggerti ❤️
Condivido tutto quello che hai scritto e citato, ma aggiungerei una cosa
sul ruolo dei social e degli influencer. Non solo questi individui difendono il
sistema che concede loro tanti privilegi con le unghie e con i denti, ma cercano di veicolare un’immagine di sé come persone “normali”, che ce l’hanno fatta grazie alla forza di volontà e il “duro” lavoro. Come Nessuno di loro dice mai di essere partito da una situazione iniziale di privilegio, con famiglie agiate che hanno permesso loro di dedicarsi a questa carriera perché non c’era necessità di guadagnarsi la pagnotta, come spesso fai notare tu. Questo crea nei follower l’illusione del “posso farcela anch’io” che ti porta a credere che vincere una PS5 ti elevi come persona, ti migliori, ti avvicini di un piccolo passo ad essere come i tuoi beniamini e a fare di tutto per ottenere di più, anche commettere un furto.